Dalla crisi al cambiamento

Nell'essere umano ritroviamo sia la natura umana (razionale) che quella sovra umana (anima) spesso nascosta, ignorata o rifiutata; quando sorgono le controversie tra la mente che vede con gli occhi della razionalità e quella che vede con gli occhi del cuore, compare il conflitto, la separazione, la crisi.
La crisi è sempre una situazione importante e delicata, che coinvolge la vita e il funzionamento psicologico di ogni persona, che comporta un mutamento personale, una riorganizzazione interna, un cambio di prospettive, non privo di difficoltà e sofferenza.
Tutta la nostra vita è piena di crisi, di riti di passaggio e di opportunità di crescita.
Nella nostra vita attraversiamo fasi critiche, ogni qual volta passiamo da una fase di sviluppo ad un'altra, quando siamo profondamente toccati da eventi significativi, o quando prendiamo consapevolezza di un presente personale difficile da accettare, o prendiamo atto di avere concluso una fase critica della nostra crescita personale.
Non sono
gli eventi esterni ad essere connotati come stressogeni o salutari a priori,
quanto, piuttosto, il come l'individuo li affronta, mettendosi in relazione
agli eventi e attivando le risorse atte a definirne i possibili esiti.

Il modello di Erik K. Erikson
Erik K. Erikson usa il termine crisi in rapporto al processo di costruzione dell'identità personale ed articola lo sviluppo della personalità in otto tappe, riferendosi alle problematiche ed ai conflitti tipici di ogni fase della vita. (2)
Il primo stadio va dalla nascita ad un anno, è chiamato orale-respiratorio sensorio e si basa sulla possibilità per il bambino di sviluppare una fiducia o una sfiducia di base, attraverso contatti che seguono una modalità incorporativa, in cui la libido si concentra sulla bocca e i sensi. Nel primo caso sviluppa con la madre un rapporto condiviso e reciproco, accetta nutrimento e protezione a acquisisce fiducia nella vita, nel secondo caso, invece, il rapporto con la madre determinerà una sfiducia di base.
Il secondo stadio, dai due ai tre anni, è caratterizzato dalla modalità del trattenere e del lasciare andare. E' la fase in cui il bambino impara ad avere il controllo dei movimenti muscolari, in cui inizia a relazionarsi con l'ambiente. Se le condizioni ambientali non saranno troppo costrittive svilupperà l'autonomia, in caso contrario diventerà dipendente, timido, insicuro e svilupperà vergogna.
Il terzo stadio, dai quattro ai cinque anni, è quello in cui il bambino si mostra curioso verso il mondo esterno, trovandosi a sperimentare lo spirito d'iniziativa contrapposto al senso di colpa. In questa fase tende a distaccarsi dai genitori, così se questi ostacoleranno le sue iniziative svilupperà aggressività e senso di colpa; se le favoriranno svilupperà voglia di agire e di conoscere.
La quarta fase, dai 6 anni all'inizio della pubertà è quella dell'industriosità opposta al senso di inferiorità corrisponde al periodo di latenza freudiano. E' un periodo importante per l'apprendimento e la socialità, in cui il bambino inizia a confrontarsi con i coetanei e a lavorare in gruppo. Le esperienze positive e costruttive porteranno il bambino a sviluppare un senso d'industriosità, competenza, e costruzione dell'identità personale, quelle negative, porteranno ad un senso di inferiorità ed isolamento.
Il quinto stadio attraversa il periodo adolescenziale ed è quello dell'identità opposto alla confusione dell'identità, in cui l'adolescente si trova a dovere conquistare una identità diversa da quella infantile. E' l'epoca dei grandi cambiamenti somatici e psicologici, che coinvolgono il gusto, l'aspetto e il carattere. Il pensiero tende a strutturarsi verso forme logiche fondate su ipotesi sociali, etiche e politiche. Se, infatti, il ragazzo nella fase precedente tende a lavorare più di fantasia, attraverso il gioco ed il suo mondo fantastico fatto di eroi e di mostri, il mondo fantastico dell'adolescente si fonda su ideali sociali, etici, politici, magari non reali ma logicamente realizzabili. L'adolescente tende a superare l'egocentrismo infantile e ad orientarsi verso la socialità, instaurando rapporti di parità con gli altri, supera la fase in cui deve avere amici solo per giocare e divertirsi, e inizia a coltivare amicizie con cui coltivare ideali o condividere idee, stabilire rapporti solidali. E' questo il momento in cui la solidarietà può associarsi alla contestazione nei riguardi dell'adulto, in cui l'adolescente assume comportamenti e condotte originali, che lo distinguano dagli altri, ma in cui al contempo ricerca, accanto al bisogno d'indipendenza, quello di avere una solida figura di riferimento. Per Erikson è questa la fase in cui esiste una identità dell'Io, che è il risultato delle funzioni organizzatrici dell'Io nei confronti del mondo esterno, e un identità del Sé, che è l'unione delle immagini di sé presenti, passate e future. Se in questa fase le due identità non si armonizzano, il rischio è quello della cosiddetta diffusione dell'Io, con la tendenza al conformismo e all'assimilazione di modelli esterni. E' questo il dilemma psicosociale dell'adolescenza, che paralizza spesso il giovane che rimane prigioniero di falsi modelli di adattamento.
Il sesto stadio è quello della giovinezza, in cui si ha l'intimità opposta all'isolamento, in cui il soggetto ha il compito di realizzare una relazione intima con un soggetto di sesso opposto. Il soggetto che non ha costruito un nucleo di identità personale, invece, non sarà in grado di costruire una relazione intima, per cui si troverà in uno stato di isolamento.
Lo stadio sette è quello dell'età adulta, in cui la genitorialità, intesa non solo come procreazione ma anche come trasmissione alle nuove generazioni di valori e speranze, si oppone alla stagnazione. La posizione opposta è quella della stagnazione e concentrazione su di sé.
Lo stadio
otto è quello della maturità e senescenza, in cui l'integrità dell'Io, che si
caratterizza per l'accettazione e la soddisfazione per il proprio ciclo di
vita, è opposta alla disperazione, definita dal senso di fallimento che vi è
insito.

Il modello di G. E. Vallant
Vaillant
G. E., ha integrato la teoria di Erikson attraverso l'inserimento di due
ulteriori stadi. (3) Dopo la fase sei, caratterizzata dall'intimità e
isolamento, colloca il consolidamento della carriera, dove il soggetto che trae
frutto dall'acquisizione di competenze e capacità creative, si motiva sempre
più, mentre quello teso all'assorbimento del sé, tende a demotivarsi. Dopo lo
stadio sette inserisce la fase del custode di significato, in cui il soggetto
pone la sua esperienza al servizio degli altri.

Il modello di J. E. Marcia
Per meglio definire la fase dell'identità dell'Io (quinto stadio) nel corso dello sviluppo adolescenziale, J. E. Marcia ha individuato quattro stati del sé o dell'identità, definiti osservando la dimensione dell'esplorazione delle possibili alternative o scelte che l'individuo è chiamato ad operare in campi diversi (scolastico, politico, religioso, sociale, affettivo ecc.), e l'impegno che l'individuo mette per intraprendere e perseguire l'alternativa individuata. (4) Secondo il modello di Marcia, che integra e non supera quello di Erikson, sono i cambiamenti cognitivi, sociali, biologici che caratterizzano l'avvio del periodo adolescenziale, a scatenare la crisi cui il giovane è obbligato a rispondere riorganizzando in nuovi equilibri le precedenti esperienze, integrandole con nuove e costruire così un migliore equilibrio. Attraverso questo processo l'adolescente potrà così raggiungere quattro possibili identità.
Un'identità stabile, in cui i soggetti sono indipendenti e riescono a vivere relazioni intime, hanno una buona autostima e capacità di resistenza al conformismo.
Un'identità differita, in cui pur godendo di un elevato funzionamento psicologico, i soggetti sono in grado di apprezzare l'intimità ma non hanno a ben presente le caratteristiche della loro identità e non sono in grado di riferire circa i loro progetti futuri.
Un'identità preclusa, derivante dalla disordinata esperienza fatta dall'individuo nel corso della fase dell'esplorazione, per cui è soggetto alla manipolazione e alle pressioni sociali.
Un'identità
dispersiva, dove a causa della mancanza della fase dell'esplorazione, il
soggetto è privo di un senso stabile dell'identità, è vulnerabile e prova
difficoltà a vivere relazioni intime.

Il modello di Berzonsky M. D.
Berzonsky, utilizzando modelli socio cognitivi, parla di stili di identità evidenziando i processi e le strategie che l'individuo utilizza nelle sue fasi di sviluppo, e individua tre stili d'identità differenti, che il soggetto tende ad utilizzare per far fronte agli eventi critici stressanti, ai problemi personali, alle richieste del contesto ambientale.(5)
Lo stile d'identità informativo, in cui l'adolescente è portato a riflettere su di sé, cercando nell'ambiente le informazioni rilevanti allo scopo d'imparare nuove competenze. Questo stile rende l'adolescente piuttosto critico e dubbioso circa le proprie convinzioni, sempre disponibile a mettersi in gioco, dotato di un Sé stabile e capace di vivere sensazioni positive di benessere psicologico.
Lo stile d'identità normativo, in cui l'adolescente tende a conformarsi a valori da lui ritenuti efficaci e appresi dagli altri. Questo stile rende l'adolescente poco tollerante verso le situazioni ambigue, dotato di un Sé resistente al cambiamento.
Lo stile
d'identità diffuso evitante, in cui l'individuo tende a rimandare troppo a
lungo scelte e a evitare il confronto su obiettivi e problemi personali. Questo
stile rende l'adolescente influenzabile, dotato di un Sé inconsistente, alla
continua ricerca di esperienze piacevoli ma vacue, approvate dagli altri.

Il modello di Luyckx K.
Il modello a quattro dimensioni, di Luyckx e collaboratori, integra la proposta di Marcia basata su due dimensioni, l'esplorazione e l'impegno, la prima intesa come meccanismo per affrontare gli impegni. (6) Gli autori si sono proposti di scomporre l'impegno e l'esplorazione in due dimensioni complementari, e tramite l'analisi fattoriale hanno elaborato un modello formato da quattro dimensioni:
Commitment Making (assunzione e scelta corrente dell'impegno)
Identification with Commitment (identificazione con l'impegno) che si riferisce al grado d'identificazione con gli impegni presi.
Exploration in Depth (esplorazione in profondità) da intendersi come una raccolta d'informazioni focalizzata solo sulle scelte correnti
Exploration in Breadth (esplorazione ampia) da intendersi come una raccolta d'informazioni a tutto campo che guidano la formazione degli impegni.
I processi che riguardano la formazione vera e propria dell'identità sono il Commitment Making e l'Exploration in Breadth, quelli che attendono, invece, il processo di valutazione dell'identità sono l'Exploration in Depth e l'Identification with Commitment.
Gli
autori hanno individuato una sequenza del modello dove ad una iniziale
attivazione dell'esplorazione ampia, finalizzata alla raccolta di maggiori
informazioni possibili che guidino le scelte e l'assunzione degli impegni,
segue l'attivazione del processo di esplorazione in profondità, finalizzata a
verificare gli impegni presi. Se tale verifica risponde ai criteri di
soddisfacimento, si attiverebbe il processo di identificazione con l‟impegno, se gli impegni assunti non dovessero risultare
soddisfacenti, si attiverebbe l'esplorazione ampia e la sequenza ricomincerebbe
dal principio.

Come superare la crisi
Per tutti gli autori sopra citati le tappe dello sviluppo sono tutte considerate un conflitto da risolvere e il loro superamento è condizionato dalla situazione socio-culturale in cui il conflitto si manifesta.
Se i conflitti tipici di ogni fase della vita sono superati con successo, avverrebbe il passaggio allo stadio successivo e l'integrazione di nuovi elementi nella costruzione della identità del soggetto. In caso di fallimento, invece, i problemi non risolti, che generano anche conseguenze comportamentali, si accumulano e si ripresentano nella fase di sviluppo successiva.
In tutti questi modelli, la crisi è sempre una fase necessaria da attraversare affinché possa esserci crescita e sviluppo.
Crisi deriva da "krino", che significa separare, discernere, cernere, valutare, e il dolore compare perché separarsi da parti di sé che non servono più, è amaro e dolente.
Così ogni tappa dello sviluppo della personalità è sempre una crisi potenziale, che comporta un cambiamento radicale di prospettiva, ed è sempre il modo di affrontarla che determinarne la crescita o l'accresciuta vulnerabilità del soggetto.
Se la crisi mette in dubbio le nostre certezze e la nostra identità, essa al contempo sollecita un bisogno di rinnovamento. Per questo le elaborazioni interne e la sofferenza che da esse deriva, hanno sempre un potenziale vitale evolutivo, che va ascoltato e ben diretto, permettendo di scoprire in noi stessi, risorse che fino allora erano a noi sconosciute. Sotto questa nuova prospettiva, la crisi è una vera e propria risorsa, un momento di crescita e di trasformazione, non una condizione da temere o evitare.
Un'occasione da afferrare e utilizzare nel modo migliore, per favorire una riorganizzazione interna più razionale, funzionale, efficiente e soddisfacente, perché per essere felici, bisogna anche imparare a trasformarsi.
L'individuo che affronta situazioni critiche diventa così competente nella ricerca di soluzioni capaci di migliorare il proprio modo di essere, ed evita al contempo di focalizzare la sua attenzione sui deficit, favorendo così la crescita personale ed il benessere.
La fase critica, fatta di elaborazioni interne delicate ed importanti, non sempre viene elaborata al meglio e si conclude positivamente, spesso si corre il rischio di rimanere bloccati in una condizione senza vie d'uscita, così essa si cronicizza.
In queste condizioni la crisi invece di esprimere il suo potenziale positivo, provoca uno stallo che genera comportamenti regressivi, che spingono l'individuo a ricercare soluzioni apparentemente utili, sviluppando dipendenze negative, situazioni apparentemente tranquillizzanti che allontanano e ostacolano la soluzione reale, malessere e disaggi psicosomatici.
Nasce così l'esigenza di uscire dalla crisi attraverso un percorso fatto di prove, di elaborazione, di purificazione, tutte finalizzate a sviluppare la comprensione e la saggezza, a favorire la crescita e la trasformazione, a facilitare una riorganizzazione interna più funzionale e soddisfacente.
L'individuo affrontando le situazioni critiche, invece di concentrarsi esclusivamente sui deficit, migliora le competenze nella ricerca di soluzioni capaci di migliorare il proprio modo di essere e riconoscere le sue competenze.
Grazie a tale percorso, migliora la sua resilienza, cioè la sua capacità di affrontare e superare gli eventi traumatici o i periodi di difficoltà. (7)
La resilienza è il risultato dell'acquisizione e del potenziamento di competenze specifiche e trasversali che, nel loro complesso, gli permetteranno di raggiungere l'auspicato cambiamento.
Le skills della resilienza acquisite sono molteplici e le esamineremo singolarmente, focalizzando le caratteristiche più salienti che è possibile acquisisce progressivamente nel tempo.
Affina il suo insight e diventa capace di esaminare se stesso facendosi domande difficili e rispondendo con sincerità
Migliora l'autostima e l'assertività e si rende disponibile a cogliere il lato buono delle cose e tende con ottimismo a sminuire le difficoltà della vita.
Riesce a mantenere una certa distanza emotiva e indipendenza dai problemi, che riesce a gestire meglio con spirito d'iniziativa, relativizzando gli eventi e vedendone gli aspetti positivi con allegria.
Diventa capace di cogliere le emozioni positive, focalizzando l'attenzione su quello che si possiede invece che su ciò che ci manca, riuscendo ad affrontare con impegno, volontà e visione positiva ciò che di volta in volta si affronta nel raggiungimento degli obiettivi.
Stabilisce rapporti d'interazione intimi con altre persone e migliora la capacità di controllare l'ambiente circostante e percepisce con maggiore finezza l'informazione proveniente da altri, che lo fanno sentire essere oggetto di amore e di cure, di essere stimati e apprezzati.
Impara ad auto ripararsi dopo un evento critico ed è capace a riorganizzare positivamente la propria vita, nonostante le situazioni conflittuali in cui si è imbattuto, perché riesce ad interpretare i cambiamenti come opportunità di crescita piuttosto che come minaccia alle proprie sicurezze e lo fa sapendo creare ordine a partire dal caos, con creatività.
Da senso
e significato alla sua vita dando maggiore importanza ai valori morali.
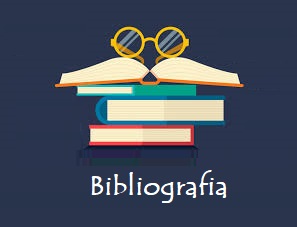
1)
ApuleioMetamorfosi2006
Mondadori2) Erikson Erik H.I cicli
della vita. Continuità e mutamenti1999
Armando Editore3)
Vaillant G.E.Adaptation to Life1977 Boston, MA, Little, Brown4) Marcia J.E., Waterman A.S., Matteson D.R., Archer
S.L., Orlofsky J.L.Ego Identity. A Handbook for Psychosocial Research2012 Springer Science & Business Media5) Berzonsky M. D.Identity processing style, self-costruction, and
personal epistemic assumptions: a social-cognitive perspective.2004 European Journal of Developmental Psychology, 1.6) Luyckx K., Goossens L., Soenens B., Beyers W.,
Vansteenkiste M.Identity statuses based upon four rather than two
identity dimensions: Extending and refining Marcia‟s paradigm.2005 Journal of Youth and Adolescence, 34, 605-6187)
Cantoni F.La
resilienza come competenza dinamica e volitiva.2014
Torino, Giappichelli Editore

